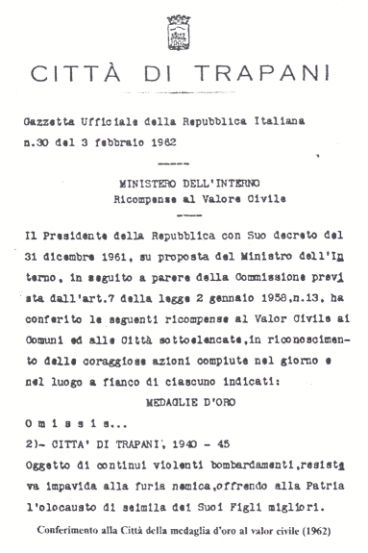|
Raccolta di poesie di Tore Mazzeo - dal libro - POESIE TRAPANESI - Baddhraronzuli 2
|
|
|
|
|
|
|
SPITALI
|
OSPEDALE
|
Letti e malati bianchi
Munachiddhruzzi fini
Çiàuri ‘i miricini
E laminteli stanchi.
‘A sira quannu scura
Letti e malati bianchi
Mura di cammaruna
E munacheddhri stanchi.
|
Letti e malati bianchi
Monache minutine
Odor di medicine
Lamentazioni stanche.
La sera quando è buio
Letti e malati bianchi
Muri di camerate
E monachelle stanche.
|
|
|
torna all'indice
|
SANATORIU
|
SANATORIO
|
Littina ri du’ banni
E ogni lettu nfilera
È un numaru chi spera.
‘U currituri nmezzu
S’arricogghi l’affanni
Chi vennu ri du’ banni
L’occhi ri ‘i littina
Talianu russi nçelu
Note esplicative, notizie, curiosità ecc.
Le poesie ‘Spitali’ e ‘Sanatoriu’ sono due composizioni scritte nell’anno
1949 concernenti due tristi episodi della mia vita. Il primo si riferisce
al ricovero in ospedale di mio padre a seguito di un grave infortunio
sul lavoro e l’altro, successivo di qualche mese, quello di una visita
al Sanatorio di Torrebianca ad una lontana parente.
Mio padre rimase quindici giorni in coma profondo ed uscì dall’ospedale
dopo un altro mese di degenza.
Ricordo che frequentavo il terzo anno di Ragioneria e mi trovavo in
classe ove stava facendo lezione il caro prof. Francesco De Stefano.
A metà dell’ora, bussando, chiese di entrare il capo dei bidelli.
Si avvicinò alla cattedra e a bassa voce si mise a parlottare col professore.
Fu così che, con molta discrezione e con parole benevoli, venni informato
dell’accaduto: mio padre era caduto dal ponteggio di lavoro ad un
metro dal soffitto della chiesa grande della Madonna mentre stava disponendo
gli operai per applicare degli stucchi di gesso.
Ricordo che nella portineria dell’ospedale trovai mia madre e la
madre di mio padre e che suor Leonina – così si chiamava la superiora –
ci accompagnò nella grande sala a due corsie di letti, ove in un angolo in
fondo al camerone c’era un letto isolato da alcuni séparé mobili in tela
bianca.
Mio padre vi giaceva dentro immobile con la testa tutta fasciata. Non
dava alcun segno di vita: da un parlottio capii o intuii che era in uno stato
comatoso.
Rinnovando quasi quotidianamente quelle visite, ho capito con quale
lena e pazienza queste suore assolvevano in maniera instancabile e puntuale
il loro lavoro da mane a sera.
Il secondo episodio, come detto, fu la visita ad una ragazza ricoverata
presso il Sanatorio di Torrebianca. Non ho ricordi nitidi, ma certamente
rimasi colpito dalle parole di conforto pronunciate da un piccolo prete
alla paziente dal viso mesto e pallido di ragazza.
|
Lettini in due filari
E ogni letto in fila
È un numero che spera.
Il corridoio nel centro
Accoglie gli affanni
Che vengon dalle due bande.
Gli occhi dei lettini
Guardano rossi il cielo
Il tetto è un bianco velo.
Queste due poesie sono state pubblicate il 27 dicembre 1951 dal
periodico IL FERRUBOTTU edito in Roma, diretto dal prof. Pietro De Giovanni,
con la seguente nota critica:«…Le sue poesie sono quanto di
più moderno io abbia potuto notare fra tutta la produzione finora inviatami.
Continui perché Lei può fare molto.»

Testata del mensile “u Ferrubottu” edito negli anni cinquanta.
|
|
|
torna all'indice
|
FUMU DI CIMINII
|
FUMO DI CIMINIERE
|
‘U fumu d’i ciminii
Niuru s’aìsa
Scantatu scantatu.
Quannu chi nforza
‘U ventu si l’arrobba.
Si perdi nçelu
Mutu
Comu ‘u duluri.
|
Il fumo delle ciminiere
S’innalza nero
Pieno di paure.
Quando rinforza
Il vento se ne appropria.
Si perde nel cielo
Muto
Come il dolore.
|
|
|
torna all'indice
|
SPIZIU DI VECCHI
|
OSPIZIO DEI VECCHI
|
Facciuzzi tribbulati
Ch’unn’hannu cchiù culuri
Manuzzi arrapacchiati
Chi çercanu caluri.
‘A sira quannu scura
‘U tremitu è cchiù forti
Rinthra ddhri quattru mura
Aspettanu la morti.
|
Piccoli visi scarni
Ormai senza colore
Piccole mani vizze
Che cercano calore.
La sera appena oscura
Il tremito è più forte
Dentro le quattro mura
Aspettano la morte.
|
|
|
torna all'indice
|
PURPITU
|
PULPITO
|
‘U parrinu jttava ira sacrali.
‘U purpitu trimava ‘gghiacciatu.
Un puvireddhru mezzu ammucciatu
Nni pruvava un sensu di mali
E la so’ panza vicinu o’ muru
Cci ntrunava com’un tammuru.
E si ‘u purpitu vuciava Diu
La panza rinthra cci ntrunava Iu.
Note esplicative, notizie, curiosità ecc.
Il purpitu è nato architettonicamente nell’antica Roma ed era costituito
da un palcoscenico più alto del pavimento di circa un metro o da una
piattaforma in grado di far vedere ed udire l’oratore ad un pubblico appositamente
convocato.
Nell’architettura cristiana era generalmente addossato ad una parete o
ad una colonna ed era sollevato da terra di un paio di metri. Vi si accedeva
da una scala fissa o mobile.
La saliva il predicatore, una sorta di oratore mistico dalla voce tonante
e fascinosa che eseguiva la predica in linea con la dottrina della chiesa
rifacendosi al Vangelo, alla Bibbia ed alla vita dei Santi.
L’eloquio di solito conteneva frasi retoriche a volte minacciose e
reboanti.
Da bambino ho assistito a qualcuna di queste prediche, e ciò è avvenuto
quando mi stavano preparando, con l’ausilio del corso di catechismo,
al Sacramento dell’Eucarestia.
Avevo otto anni.
|
Il prete gettava grida sacrali
Il pulpito tremava ghiacciato
Un poverello seminascosto
Ne provava un senso di male
E la sua pancia vicino al muro
Gli rintronava come un tamburo.
E se il pulpito gridava Dio
La pancia dentro rintronava Io.
La scena descritta dalla poesia, ora forse un po’ esaltata dallo sforzo
di memoria, è ancora davanti ai miei occhi.
Ero seduto assieme a mia nonna in sedie col fondo di corda, prelevate
a pagamento dal seggiaru*. Eravamo vicino al pulpito (mia nonna era
un po’ sorda) e su di esso era il predicatore, forse un monaco con una
barba bianca. Giù, ma all’impiedi, vicinissimo al pulpito, un poveruomo
con la barba ispida e i calzoni grigi con i rivolti a mezza gamba; certamente
un marittimo o un pescatore o comunque un uomo che aveva tutte
le carte in regola per incarnare nella mia fantasia un peccatore.
Lo immaginavo digiuno da un paio di giorni e siccome era un po’ obeso,
ritenevo che le parole del predicatore gli facessero intronare la pancia.
Queste cose non me le invento, ma mi sforzo di ricordarle così come
allora immaginavo che fossero.
————————————————————
* Siggiaru: noleggiatore di sedie, ma anche artigiano che, nelle grandi occasioni di
feste religiose, eseguiva con propri materiali e attrezzature addobbi ed abbellimenti
ad altari o sepolture o altri luoghi sacri usando diverse specie di stoffe (falsi broccati,
velluti, sete ecc.), nastri, passamanerie (cordoni, falsi pizzi, decorazioni in metallo,
ecc.). Era quasi quello che è oggi un operatore scenografico.
|
|
|
torna all'indice
|
PUVIREDDHRA
|
POVERELLA
|
‘Nthra ‘i scaluna di la chiesa scuri
R’un niuru mantu nesci ‘na tistuzza
Sicca e scavata pi ‘u so’ duluri
Ch’appara trimuliannu ‘na manuzza.
L’occhi calati nterra sta fiura
viri sulu ‘i scarpi ri li genti
Mentri o’ so’ pettu stringi ‘na creatura
Chi di sucari mancu si la senti.
‘I scarpi sunnu sempri nmovimentu
Cangianu furma, cangianu culuri
La manu è bianca com’un munumentu
‘Ntra ‘i scaluna ri ddhra chiesa scuri.
Note esplicative, notizie, curiosità ecc.
Quando ero ragazzo, le poverelle stavano soltanto “d’arrè ri porti ‘i
chiesi”. Alcune, come tacito invito all’obolo, stendevano le misere mani
sporche di miseria; altre le tendevano con un barattolo ex Cirio o Elvea
che, al tremore causato dal parkinson o dal freddo, faceva tintinnare le
poche monetine di acmonital già raccolte.
La loro miseria la mostravano dal sembiante, dalle logore vesti e, a
volte, la completavano, quasi musica di scena, col triste piagnisteo d’ un
bambino, tenuto tra le braccia avvolto in un lacero sciallino.
Esse ringraziavano i benefattori con un sorriso scolorito accompagnato
da un incomprensibile mormorio o da un “recamaterna ae mortiçeddhhri
vostri” o con una anafora” ‘u Signuri v‘u paga… ‘u Signuri v’u paga”.
Facevano tenerezza: ispiravano buoni sentimenti.
|
Fra gli scalini della chiesa oscuri
Da un nero manto esce una testina
Scavata e ossuta per il suo dolore
Che stende tremolante una manina.
Gli occhi fissi in terra la figura
Vede solo le scarpe della gente
Mentre al petto stringe una creatura
Che di succhiare neanche se la sente.
Le scarpe sono sempre in movimento
Cambiano forma, cambiano colore
La mano è bianca com’un monumento
Fra gli scalini della chiesa oscuri.
Il popolo ecclesiale era un popolo festivo: andava in chiesa solo la
domenica o nelle feste comandate.
Il popolo quotidiano, invece, al quale sono ora interessati i moderni
poveri, è quello dei passanti motorizzati che hanno l’obbligo di fermarsi
al rosso dei semafori. In quel luogo gli automobilisti divengono le prede
di giovani donne extracomunitarie, benvestite, dalle mani curate, i capelli
sciolti e, non di rado, un lieve maquillage invisibile ai distratti guidatori.
Esse avanzano tra le file delle auto ferme con un lieve sculettio, esponendo
sorrisetti melliflui, recando tra le mani una lattina di birra o di coca
cola. Davanti all’automobilista sprovvisto di monetine frenano i sorrisi
ed ingranano un’espressione di biasimo, mentre all’altro, che dall’atteggiamento
intuiscono essere un donatore in fieri, elargiscono inaspettati
sorrisi seguiti da uno ciao tra l’amichevole ed il confidenziale ma che
rappresenta un implicito invito alla oblazione in un prossimo passaggio.
Tra recamaterna e ciao è passato quasi mezzo secolo.
|
|
|
torna all'indice
|
TRI JORNA DOPU
|
TRE GIORNI DOPO
|
Vinistu a tradimentu
e nn’-on mumentu
San Petru scumparìu
sutta ‘u bombardamentu.
E d’unni c’eranu casi bianchi
di cantuna russicati du sali
e r’i mali vintati,
casi nichi chî maruna avvaddhrati
chî mura allattati
chî porti schicchiati
chî nassi pinnuliati
dî travi ngrasciati
du fumìggiu du lumi,
ma r’unni la vita scurrìa
nmezzu ‘na sthritta via
chi finìa nn’-on curtigghiu
‘unni ‘na funtaneddhra
quannu l’avìa nvulìu
currìa sempri a pilìu.
(segue)
Note esplicative, notizie, curiosità ecc.
Tra i numerosi bombardamenti che la città di Trapani ebbe a subire
nel corso dell’ultimo conflitto mondiale, il più funesto e distruttivo si
verificò il 6 giugno 1943.
Fu un bombardamento dal mare e dal cielo effettuato da due grosse
navi e da tre ondate di un centinaio di fortezze volanti.
|
Veniste a tradimento
ed in un momento
San Pietro scomparì
sotto il bombardamento.
E dove erano case bianche
di tufi corrosi dal sale
e dai cattivi venti,
piccole case con i mattoni sconnessi
con i muri imbiancati
con le porte sgangherate
con le nasse penzoloni
dalle travi luride
di fumiggio del lume,
ma dove la vita scorreva
in mezzo ad una stretta via
che finiva in un cortile
dove una fontanella
quando poteva
correva sempre a gocce.
(segue)
Malgrado che la popolazione civile fosse già sfollata nei piccoli paesini
dell’agro ericino, si disse allora che le vittime di questo ultimo bombardamento
ammontavano e forse superavano il numero di 5.000 unità
tra civili e militari.
Obbiettivo militare da colpire era il porto, il quale si trova ad una ventina
di metri dal popoloso quartiere di San Pietro.
Dopo tre giorni, mio padre decise di scendere da Erice a vedere che
cosa fosse successo alla nostra casa.
|
|
sipulcru senza lapida.
E sutta ‘u mari di cantunazzu
assummanu chini di purvirazzu
tavoli e trispa spaccati
matarazzi spanzati
linzola squartariati
pignati di crita scurciati
pareddi spunnati
e autri cosi svicchiarati.
Sulu sti cosi ddhra sutta
‘i poveri morti cunurta.
Vinistu a tradimentu
E ndo ‘n mumentu
San Petru scumparìu
pi lu bombardamentu.
Scendemmo a piedi dal monte e fummo in mezz’ora a casa nostra.
Eravamo giovani: io avevo 17 anni; mio padre 42.
Abitavamo in via Orlandini; abbiamo trovato tutto in ordine.
Con mio padre andammo a vedere il quartiere di San Pietro.
Non lo trovammo: era sparito!
C’era soltanto quanto descritto nella poesia.
|
Ora quel luogo è diventato
sepolcro senza lapide.
E sotto un mare di sfabbricidi
sporgono pieni di polvere
tavole e trespi di letti rotti
materassi spanciati
lenzuola strappate
pentole di coccio scorticate
padelle sfondate
e altre cose vecchie.
Solo queste cose là sotto
i poveri morti consola.
Siete venuti a tradimento
E in un momento
San Pietro scomparì
sotto il bombardamento.
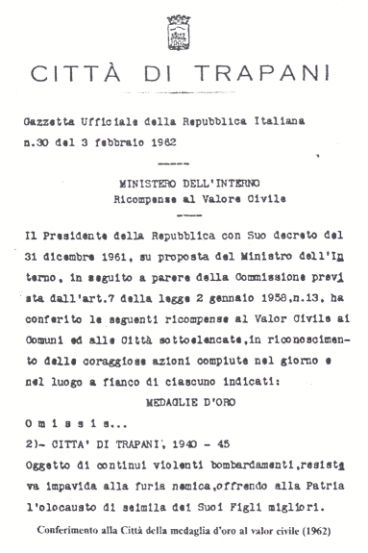
|
|
|
torna all'indice
|
‘A PRIMA MISSA A SAN PETRU DI MATINA
|
La prima messa a San Pietro di mattina
|
San Petru avi apertu ‘u so’ purtuni;
sunnu a momentu ‘i sei: è quasi iornu!
‘U sarristanu sona ‘u campanuni
chi chiama ‘a prima Missa di stiornu.
A picca a picca trasinu ‘i cristiani,
povera genti vistuta di travagghiu:
un vecchiu scuffunia ‘na cucchia ‘i pani:
‘na lavannara teni nvrazza ‘u figghiu.
Ogni vota chi trasinu ssi genti
‘u silenziu s’accogghi ‘i scrusci e ‘i vuci:
‘na speci di runguli e lamenti
chi la navata astuta a taçi-maçi.*
Ma ‘u silenziu, picca picca dura
corpi ri tussi, stranuti libbirati
stanchi lamenti di ‘na criatura
scacchi spitturati rimannati.
Chianti d’un nuzzenti: ‘oli sucari,
lamenti di du’ vecchi c’u sbarigghiu,
matri confusa chi cerca d’annacari,
vuci ‘i sciarra chi vennu d’un curtigghiu.
Scrusci ‘i scarpi chi tacci ri surdati:
è ‘u parrinu chi si li strascinìa,
patri Corsu avi ‘i naschi sbarrachiati,
e caminannu si li tabacchìa.
S’infila p’a vistuta n-Sacristia
si metti nprescia e furia i paramenti
nno’ specchiu si talìa e pizzichìa
pigghia tabbaccu e fa scutulamenti.
|
San Pietro tiene aperto il suo portone
a momenti son le sei: è quasi giorno!
Il sacrestano suona il campanone:
chiama alla prima Messa d’oggi giorno.
A poco a poco entrano i cristiani
vestiti da lavoro e rattoppati,
un vecchio tiene in mano un grosso pane,
una donna dà al suo bimbo le poppate.
Ad ogni mesta entrata della gente
coglie il silenzio le voci ed i rumori,
una specie di rantolo e lamento,
che com’un eco in navata muore.
Il silenzio pochissimo perdura:
arrivan tossi e starnuti liberati
stanchi lamenti d’una creatura
e liquami espettorati rimandati.
Pianto d’un lattante; vuole poppare,
lamenti di vecchiette con sbadiglio
madre confusa che non sa che fare
voci di sciarra che vengon da un cortiglio.
Rumor di scarpe chiodate per soldati:
è il prete che li strascina al suolo
padre Corso ha le froge spalancate
e camminando fiuta quasi a volo.
S’infila per vestire in Sacrestia
indossa in fretta e furia i paramenti
allo specchio si guarda e ‘pizzichia’
pulisce il petto dai tabaccamentii.
|
|
E quannu si nn’acchiana nna’ l’altari
e accenna la duvuta nginucchiata
accumincia ‘u latinu a spirugghiari
e ‘a genti arrispunni nsunnacchiata.
‘A Missa durava un quartu d’ura
Patri Corsu sapia soccu avia a fari
biniricia ‘a genti cu primura:
sapìa c’avia a gghiri a travagghiari.
Note esplicative, notizie, curiosità ecc.
Siamo negli anni ’30.
La Chiesa di San Pietro è una specie di Cattedrale dei poveri, anche
se a norma di diritto canonico era stata elevata ad Arcipretura collegiata
e il religioso che la dirigeva doveva essere, ed infatti lo era, un Arciprete,
per la precisione Giovanni Ardito.
Essa sorge nel bel mezzo del quartiere chiamato “Casalicchio”, il
quartiere più antico e il più animato della città, vicinissimo al porto.
Il luogo era principalmente abitato da marittimi e pescatori, da salinai
e da scaricatori portuali, gente che lavorava due o tre mesi l’anno e che
da marinai si trasformavano, alla bisogna, in pescatori e da scaricatori in
salinai e tonnaroti (Trapani, aveva inventato la flessibilità dei poveri).
Erano, per lo più, questi i lavori accessibili alla cosiddetta manovalanza
che si svolgevano nel quartiere del Casalicchio o nelle vicinanze.
* taçi-maçi: lemma binato detto di quando si vuol fare qualcosa (di bene o di male)
di nascosto, proprio a taçi-maçi.
|
E quando sale ben svelto su l’altare
s’alza a stento dall’inginocchiata
parla latino la gente sta a guardare
e non risponde è come insonnacchiata.
La Messa durava un quarto d’ora
Padre Corso sapeva il suo da fare
benediceva la gente con premura
perché dovean andare a lavorare.
Altri uomini, quando ne era la stagione, praticavano la pesca delle
spugne e perciò s’imbarcavano come marinai o mozzi nelle barche lunghe
per arrivare a Sfax, nella vicina Tunisia, ove con il solo ausilio dei
loro polmoni abbuddhravanu, cioè s’immergevano in apnea oltre i dieci
metri, per portare alla superficie le spugne. Ciò accadeva per un paio di
mesi l’anno con quali conseguenze è facile immaginare.
Nel quartiere c’erano anche molte botteghe di artigiani per lo più praticanti
mestieri connessi con le attività produttive del luogo, cioè funai e
cordari, maestri d’ascia, calafati, bottai ed altri, che per le normali esigenze,
praticavano lavori stanziali o ambulanti, come stagnari e ramai,
costruttori di nasse e reti, calzolai, fabbri e lavandaie per il bucato al domicilio
dei benestanti portando spesso il lattante appresso. E c’erano anche i
preti che facevano quel che potevano, qualche volta senza speranze.
La prima Messa a S. Pietro era nota come quella dei rumori corporali.
Questa caratteristica era tanto risaputa che quando in altri luoghi si
verificavano pubblicamente quelle medesime rumorose manifestazioni,
c’era sempre qualcuno che, con toni canzonatori, diceva: Mi pari r’esseri
a’ prima Missa a San Petru..
|
|
|
torna all'indice
|
TURMENTU
|
TORMENTO
|
Quannu ‘u iornu cari
E l’ultima lusthrura
S’arresta a succannari
Nascinu li pinseri
Aràçiu araçiu
Comu ‘a siritina.
Poi criscinu arditi
Comu la notti
E ’u scuru l’accumpagna
Nfunnu nfunnu
L’ammisca tutti.
Un urlu ranni
Ch’un si senti c’aricchi
Allura
Rintrona ncori
Forti forti.
|
Quando il giorno cade
E l’ultimo lucore
Resta smarrito in aria
Nascono i pensieri
Poco a poco
Come la sera.
Poi crescono arditi
Come la notte
E il buio l’accompagna
Nel profondo
Li mischia tutti.
Un urlo grande
Che le orecchie non sentono
Allora
Rintrona in cuore
Forte forte.
|
|
|
torna all'indice
|
‘U FUNERALI
|
IL FUNERALE
|
La carrozza camina a passu lentu
carrica di ghirlandi arriccamati
e mprima fila ‘i parenti a stentu
tratteninu lu chiantu ncapputtati.
Supra ncassetta ‘u gnuri tisu tisu
cu ‘u cappeddhru di carrabbineri
teni ‘na smorfia trista nno’ so’ visu:
’a smorfia fissa di lu so’ misteri.
I bicchina a çiancu d’a carrozza
di niuru vistuti e ntunacati
s’annacanu e caminanu pi fforza
comu si zzoppi fussiru o sciancati.
’A genti chi s’attrova æ lati ‘a strata
si leva ’u cappeddhru a mezza testa
si tocca qualchi cosa… accutturata
e s’incamìna arrè cchiù forti e lesta.
Note esplicative, notizie, curiosità ecc.
Note esplicative, notizie, curiosità ecc.
È la descrizione di un “accompagnamento” funebre al Cimitero
comunale.
Dopo la benedizione della salma fatta in Chiesa, il feretro veniva sistemato
nell’apposita “carrozza dei morti” trainata da due, quattro o sei
cavalli, con tutti i fiori formati a ghirlande appese attorno al carro.
|
La carrozza procede a passo lento
carica di ghirlande ricamate
in prima fila i parenti a stento
trattengono i pianti incappottati.
In cassetta il cocchier teso nel viso
con il cappello da carabiniere
tiene una smorfia triste sul suo viso
la smorfia fissa del suo bel mestiere.
I becchini che affiancan la carrozza
vestiti in nero ed intonacati
camminano pian pian, quasi per forza
come fossero zoppi oppur sciancati.
La gente ch’ è ai lati della strada
si toglie il cappello a mezza testa
si tocca qualche cosa scostumata
e prende a camminar più forte e lesta.
Si formava il cosi detto “accompagnamento” a piedi dal quale erano
escluse le donne.
In prima fila i parenti intimi, a seguire gli amici, dietro carrozze da
nolo nelle quali, se volevano, erano ospitate le donne di casa.
|
|
|
torna all'indice
|
‘A MORTI
|
LA MORTE
|
‘U dutturi taliau ddhru puvireddhru
Giannu e affannatu dinthra ‘u littiçeddhru
Nisciu ‘u stituscopiu e l’ascutau
E cu l’occhi a mezza finta ‘u taliau.
‘U poviru malatu ntra lu lettu
C’avia un gran duluri nfunnu o’ pettu
Pinsau ch’era tutta misa in scena
Pi faricci pruvari menu pena.
Siccome unn’era ancora arripuddhrutu
Capiu chi lu so’ iornu era arrivatu
E c’u anticchia d’u so’ sintimentu
Calau la testa pi’ ringraziamentu.
Araçiu araçiu vinni lu parrinu.
Cu cammisotto biancu e lungarinu.
I parenti si schieraru a manu manca
L’ostia ci retti nna’ la vucca bianca.
Ma prima di spirari ad occhi chiusi
Cci vinniru pinseri purtintusi
E nt-on minutu a menti arripinsau
A tutta la so’ vita chi passau.
Vitti i cosi larî e li scartau
Vitti li malazzioni e l’abbruciau
I cosi beddhri nda l’occhi si li tinni
E a la morti cci dissi: emuninni.
|
Il medico guardò quel poverello
giallo e affannato dentro il letticello
prese lo stetoscopio e l’ascoltò
e con gli occhi bugiardelli lo guardò.
Il povero malato di quel letto
che aveva un gran dolor in fondo al petto
pensò ch’era tutt’una messa in scena
per non fargli provare una gran pena.
Siccome non era ancora strampalato
capì che quel giorno era arrivato
e con un poco del suo sentimento
lieve assentì per un ringraziamento.
E a passo lieve arrivò il pretino
con la cotta bianca d’organzino.
Da un lato si misero i parenti
per consentir il dar dei sacramenti.
Ma prima di spirar ad occhi chiusi
gli vennero pensieri portentosi
e in un minuto la mente sua pensò
a tutta la sua vita che passò.
Vide le cose brutte e le scacciò
vide le brutte azioni e le scartò
le cose belle negli occhi se le tenne
ed alla morte disse: jamonenne.
|
|
|
torna all'indice
|
‘U TRIBBUNALI
|
IL TRIBUNALE
|
L’avvucatu parlava e straparlava
l’imputatu alluccutu l’ascutava
pi’ fatti so’ lu jurici pinsava
e c’a matita un fogghiu disignava.
L’avvucatu ‘a toga s’aisava
ma muvennusi assai cci sciddhricava
l’imputato scantatu lu taliava
‘u jurici pi’ sutta si rattava.
Ma quannu chi finìu la ran ‘rringata
l’imputatu pruvau ‘na riçialata
‘u jurici si nni jiu nna’ ritirata
e si fiçi cuntentu ‘na pisciata.
Mperi ristaru i du’ carrabbineri
cu i caddhri addumàti nna li peri
e un cristianeddhru afflittu: ‘u cancilleri
c’a testa china china di pinseri.
‘U jurici trasiu cu la scazzetta
l’avvucatu ‘stutau ‘a sigaretta
l’imputatu nisciu du’ fazzuletta
‘u nasu si çiuçiau comu trummetta.
‘U jurici liggennu ammintuava
numari e littri e tuttu si priava
l’imputatu alluccutu l’ascutava
senza che la so’ menti cci arrivava.
|
L’avvocato parlava e straparlava
l’imputato allocchito lo ascoltava
ai fatti suoi il giudice pensava
con la matita un foglio disegnava.
L’avvocato la toga si rialzava
ma muovendosi in giù gli scivolava
l’imputato impaurito lo guardava
il giudice di sotto si grattava.
Ma quando finì la grand’arringata
l’imputato provò una respirata
il giudice andò in ritirata
e si fece contento una pisciata.
In piedi restaro i due carabinieri
con i calli infocati nei lor piedi
e un pover cristo: il cancelliere
con la testa assorbita dai pensieri.
Il giudice entrò con la scazzetta
l’avvocato spense la sigaretta
l’imputato tirò due fazzoletti
il naso si soffiò come trombetta.
Il giudice leggendo enunciava
numeri e lettere e se n’allietava
l’imputato attento l’ascoltava
senza che la sua mente v’arrivava.
|
|
Note esplicative, notizie, curiosità ecc.
|
|
|
|
torna all'indice
|
NNI VIRIAMU ‘A DUMINICA MATINA
|
CI VEDEVAMO LA DOMENICA MATTINA
|
Mi votu e mi svotu:
mi pari sugnu sulu nna’ stu munnu
l’amici me’ mi stannu abbannunannu.
A unu a unu:
a chi li viu a chi si nni vannu,
‘un vennu cchiù picchì nun ci la fannu.
A unu a unu:
sunnu arridutti all’ossu; su’ malati
e quarchirunu ‘un nesci cchiù pi strati.
A unu a unu:
‘i staju pirdennu tutti, chi sfurtuna;
‘a caruta, ‘u catarru, ‘a cacareddhra?
Ma quannu mai, ora i tri C finèru*
cci su’ autri malanni, chi futtuta:
cu avi ‘u cancru, cu l’ernia iatali,
cu avi ‘a diabeti, cu ‘a pressioni,
cu avi ‘a testa tutta ncunfusioni,
cu avi ‘i vermi e cu ‘u trimulizzu.
A unu a unu:
ma ‘nn’è chi tocca a mia pacari ‘u pizzu?
Note esplicative, notizie, curiosità ecc.
Quando iniziò il tacito, poi consolidato appuntamento, eravamo una
dozzina di amici, quasi coetanei.
|
Mi giro e mi rigiro:
mi sembra d’esser solo in questo mondo
I miei amici mi stanno abbandonando.
A unu a unu:
ora li vedo e poi se ne vanno,
non vengon più perché non ce la fanno.
A unu a unu:
sono ridotti all’osso, son malati
e qualcuno non esce più in strada.
A unu a unu:
li sto perdendo tutti, che sfortuna;
la caduta, catarro, cacarella?
Ma quando mai, finiron le tre C*,
ci sono altri malanni, che fottuta:
chi ha il cancro, chi l’ernia iatale,
chi il diabete, chi la pressione,
chi ha la testa tutta in confusione,
chi ha i vermi e chi il tremolizzo.
A unu a unu:
per caso tocca a me pagare il pizzo?
Ma gli anni passano; ne sono passati quasi una ventina: i più se ne
sono andati, i meno son restati.
Ma per quanto ancora?
Mi consolo con la poesia.
* Le tre “C”: erano i malanni che generalmente colpivano, nei tempi passati, le persone
di una certa età e le conducevano alla morte.
|
|
|
torna all'indice
|
pagina a cura di
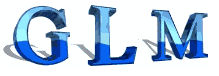 per CORRAO editore
per CORRAO editore
|